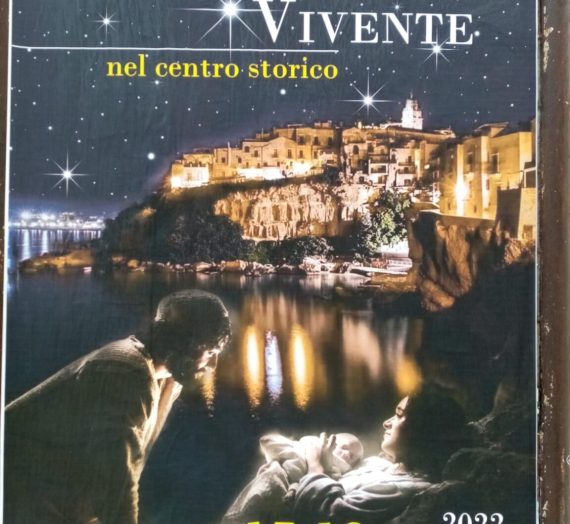Abbronzati a sinistra – Intervista a Elio Paoloni
Dalla geografia astronomica: nel nostro emisfero il percorso quotidiano del sole è sempre spostato verso sud e i pellegrini, avanzando verso Occidente, lo hanno costantemente sul lato sinistro.
Perché ha deciso di scrivere un libro sul Cammino di Santiago? Cosa differenza il suo libro dai moltissimi già scritti sul Cammino?
Diciamo che questo libro non doveva nascere. Avevo deciso di vivere l’esperienza senza mediazione e per evitare il filtro di cui parlava Sartre (lo scrittore non guarda mai un tramonto bensì la descrizione di un tramonto) non avevo portato neppure un taccuino, tanto che ho avuto problemi anche a ricostruire molti dettagli del percorso, in seguito. Doveva essere un’esperienza intima, punto. Dopo diverso tempo però lo scrittore ha preso il sopravvento. Prima di tutto, per me stesso: se non ne scrivo nessuna esperienza mi è davvero chiara; non riesco ad elaborarla, a far sì che mi arricchisca davvero, e soprattutto non riesco a lasciarmela alle spalle. Una volta descritta, poi, mi sono reso conto che per quanto intimo, quel viaggio – con le riflessioni che ne scaturivano – rispecchiava le inquietudini spirituali di molti e che portarlo al pubblico diveniva doveroso.
La seconda parte della domanda è fondamentale per l’eventuale lettore: è proprio vero che ci sono fin troppi libri sul Camino, ed è inevitabile chiedersi perché mai ne sia necessario un altro. È vero, i diari di viaggio sono tutti simili, spesso stucchevolmente devoti. Quelli dei nipotini di Coelho, poi, sono ancor più melensi e non mette conto di parlare di quelli fieramente atei, come quello di Odifreddi con (o contro) Valzania. Qui però lo sguardo del narratore è diverso: il narratore è sempre sul crinale tra fede e scetticismo. È questo combattimento a renderlo unico. La scrittura è spiazzante, ironica, spesso sarcastica, ma anche commossa e profonda. Un critico scrisse che io “tendo agguati”. In effetti usavo pescare in apnea, “all’agguato”. E sono convinto che questo libro non annoierà.
Lei dichiara che il suo libro è un romanzo e non un reportage: ha fatto davvero il cammino, ma poi ha preferito proporlo sotto forma romanzata. Perché?
Cominciamo col dire che per un editore qualsiasi prosa che non sia saggistica o raccolta di racconti è in automatico un romanzo. Marketing a parte, ciò che ne fa un romanzo è la qualità e la profondità della scrittura, oltre a quella parte di invenzione, o di falsificazione, che è propria di qualsiasi diario, anche il più intimo e segreto.
“Tonda, sonora, sillabata: è con una sacrosanta bestemmia che comincia il santo viaggio”. Poi migliora?
Ovviamente sì. Nonostante i moti di sfiducia, nonostante tutta l’ironia e l’autoironia dispensata a piene mani nel testo, mi sono fatto una convinzione: quali che siano le motivazioni di coloro che fanno il cammino, tutti, in qualche modo, finiscono per risentire dell’effettiva spiritualità del tragitto; senti davvero, a un certo punto, di camminare insieme agli altri, non intendo quelli intorno a te, no, mi riferisco alle migliaia di pellegrini che lo hanno fatto nei secoli. Avverti questa fiumana di persone. Cammini nel tempo, non solo nello spazio. E tutti, mi piace pensare, vengono toccati dall’Apostolo.
La risposta, dunque è sì, il suo sporco lavoro il Camino lo ha fatto: alla fine (non solo per il Camino, ovviamente) sono tornato a casa, e per casa intendo la Chiesa. Del resto, se anche non fossi credente mi definirei in ogni caso cattolico apostolico romano. Perché è la tradizione dei miei avi, perché siamo comunque intrisi di cattolicesimo e soprattutto perché ciò che propugna la Chiesa è esattamente ciò che ogni società sana, strutturata, che intenda sopravvivere, dovrebbe seguire. Ma già la bestemmia dimostrava un fervido legame con la divinità: menzionare Dio o un Santo significa riconoscerne l’esistenza e il potere. Si è mai sentito qualcuno bestemmiare il Nulla o il Caso? Infatti le più bersagliate sono le figure prossime, Patroni e Protettori. Rischiando la blasfemia potremmo dire che ogni imprecazione è una rude preghiera, una maschia, orgogliosa protesta. Una richiesta di attenzione, come quando i bambini ignorati mandano in frantumi un oggetto.
Quello che lei racconta è un viaggio sul filo tra fede e scetticismo. Qual è il confine?
Penso che la Fede, con l’eccezione, forse, di qualche Santo, non è data una volta per sempre. Il dubbio, questo frutto avvelenato della Ragione, è sempre in agguato. Gesù stesso ebbe – se interpreto bene – almeno un momento di dubbio. Quella che racconto è la condizione di ogni credente, o di chi vorrebbe disperatamente credere, di chi, come il personaggio di Huysmans citato in esergo, “si imbarca da solo, nella notte, sotto un firmamento che non è più rischiarato dai consolanti fari dell’antica speranza”.
Lei a un certo punto dice che “Ogni cammino è quello giusto. E soprattutto è sempre un compromesso”. Ci può spiegare?
Mi è capitato spesso di cercare il “modo giusto” e soprattutto di criticare il “modo” degli altri. Ogni volta ho finito per rendermi conto che anche il più criticabile degli approcci aveva un senso, delle motivazioni valide, di come potesse risultare addirittura più eroico o più filologico del mio. E di quanto la ricerca della filologia possa portare fuori strada: “se i nostri predecessori avessero avuto a disposizione la carretera nacional non avrebbero esitato un secondo a imboccarla, altro che bucolici sentieri”. Il compromesso è il modo stesso della vita, è la risultanza dello scontro tra ciò che l’uomo propone e ciò che viene disposto. Più prosaicamente, in un viaggio che dipende grandemente dalla meteorologia, dalla fisiologia, dalla casualità, occorre trovare di continuo degli accomodamenti, degli aggiustamenti, specie se si viaggia in compagnia. E ciò fa parte del percorso di crescita, anche spirituale. L’adattamento, l’elasticità, la sopportazione non restano al livello della praticità: sono una lezione di vita. Uno dei grandi insegnamenti del camino è quello di fare davvero a meno del superfluo, e quando dico superfluo, intendo anche il terzo paio di mutande – due bastano, una addosso, l’altra ad asciugare, magari appesa allo zaino, se non c’è tempo. Si impara ad andare leggeri, a fare a meno di tutto, si scopre che gran parte di ciò che ci circonda normalmente è inutile. Infatti sui sentieri o negli ostelli si trovano un sacco di oggetti abbandonati. Man mano che si procede ci si alleggerisce. Anche la mente deve alleggerirsi, per recepire meglio. Questo della leggerezza sembra un dettaglio pratico, dato che uno zaino più pesante di sei chili ti porta inevitabilmente a danni fisici, in realtà è anche un imperativo spirituale, che riporta il pellegrino ai precetti evangelici: E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. Questa del non portare due tuniche è una prescrizione incredibile, così precisa, prosaica, quasi comica nell’ossessione del guardaroba, eppure non può non nascondere qualcosa di più profondo.
Perché secondo lei è il moto, e non la stasi – si pensi alla meditazione buddhista –, ad avvicinare a Dio?
Se dovessi pensare a una spiritualità nella stasi guarderei più a Sant’Ignazio o a Giovanni della Croce che alle tecniche orientali. Ma il moto è fondamentale. Anche i processi spirituali dei mistici vengono metaforicamente definiti cammini. L’atto del camminare è così profondamente radicato in noi – e al contempo ormai quasi precluso – che compiendolo si ritorna a una dimensione naturale, più umana, che ci predispone alla trascendenza. La fatica, la natura intorno e soprattutto la concentrazione continua, di tutta la giornata, ogni giorno, sulla meta finale, predispongono a uno stato di coscienza più ricettivo. Il pellegrino, diceva l’allora Cardinale Ratzinger in una omelia “girovaga, per così dire, nella geografia della storia di Dio. Prestando attenzione ai segnali che la Chiesa, per la potenza della sua fede, ha predisposto, i pellegrini hanno la possibilità di trovare davvero ciò che il turismo cerca”.
Pensa di ripetere l’esperienza del pellegrinaggio?
Più che ripeterla dovrei concluderla (mi manca qualche centinaio di chilometri – ovvero l’inizio – per completare il frances, il Camino classico). Ho riluttanza alla ripetizione, però. Sono rimasto un po’ turbato dai tanti che hanno ripercorso più volte il Cammino. C’è gente che lo fa ogni anno, per anni (di solito finiscono per fermarsi a fare gli hospitaleros, a gestire un albergue). Mi è sembrata una dipendenza: è come se non fossero riusciti a fare tesoro del Cammino, a portarne i frutti nella vita di ogni giorno: se occorre tornare continuamente all’eccezionalità del Cammino vuol dire che l’esperienza è fallita, in un certo senso. Questo doversi immergere necessariamente in una dimensione atipica assomiglia a una fuga dalla realtà. Ma anche questo è giudicare, e criticare gli altri pellegrini, come ho già detto, è quanto di più lontano dallo spirito del Cammino.