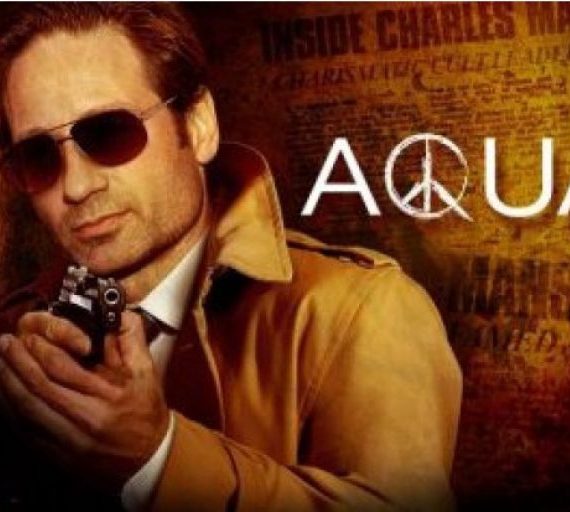Budapest e le sorelle. Un reportage sentimentale

di Francesca Mazzucato, in Viaggio, del 15 Nov 2018, 11:01

L’amore è un mare senza sponde
e in questo mare senza limiti non c’è alcun aiuto.
Chi salpa mai più rivolge il suo sguardo verso la terra e tutta via,
sono felice di partire per questo viaggio,
perché è meraviglioso navigare in questo mare.
Che importa se anche il viaggio più lungo alla fine giunge a termine
che importa se la più maestosa delle navi alla fine affonda
…quante menzogne hai amato,
quante parole hai creduto,
che venivano solo da un curvarsi di labbra,
e il tuo stesso cuore
cosí mutevole, senza fondo e preda dell’attimo –
quante menzogne hai amato,
quante labbra hai cercato
(«togliti il rossetto dalla bocca,
dammela pallida»)
e sempre piú domande –
Gottfried Benn
Parto dal mare per arrivare al Danubio. Parto dal ponente estremo per arrivare a est. Terra di frontiera- Budapest e ritorno, questo è il programma, il mezzo è il bus che mi consente gli orari giusti senza cambiare e aspettare in un posto senza nome o negli aeroporti terrorizzata da possibili cancellazioni. Amo il viaggio lento, che scandisce l’avvicinamento e fa percepire la durata solida e precisa di ogni tappa.
Passare frontiere sul Flixbus, è uno dei miei piaceri, osservo cosa accade o cosa non accade, lascio le cose dall’altra parte. Le parcheggio, come se ci fosse un immaginario spazio a disposizione per i bagagli della memoria e, una volta dall’altra parte, solo leggerezza. Da qualche tempo mi muovo sempre per le stesse ragioni: una città dell’Est, una conferenza della mia associazione, IATEFL, insegnanti di inglese da tutta Europa che si ritrovano e che fanno il punto, si rivedono, condividono ricerche, allargano prospettive. Sono già stata a Bratislava quest’anno per lo stesso motivo. Corro un rischio, fare un paragone continuo e non voglio, è una cosa delicata fare paragoni. Bratislava è una nuova capitale dove vado spesso, la amo con tutto il cuore per le sue imperfezioni, per le presunzioni ridicole, per le periferie che si inchinano ogni volta che ci torno, per le simmetrie non azzeccate: Soprattutto per i panorami di luci basse che mi commuovono, la luce della Slovacchia, se non la si conosce si manca qualcosa di denso e indimenticabile, una sfumatura importante, la luce più lontana dal bianco che ci sai. La luce densa grondante, il nido delle sere solitarie e di quelle clandestine. Budapest è altro. La sua luce non la ricordo ma è una capitale antichissima e gloriosa dove sono già stata molti anni fa, il primo assaggio di Europa dell’Est. Forse il primo viaggio che mi portava lontano dai percorsi confortevoli, Londra, Oxford, Cambridge, ancora Londra, poi Parigi, Marsiglia, Lione, ancora e ancora Parigi, ancora e ancora Marsiglia (La città di Z sulle orme di Joyce, laggiù oltre il Gottardo dove ci sono lui e Canetti accanto a cui riposare e dove ho trovato il fiume e ho sperimentato la passione senza rimedio, è arrivata molto tempo dopo Budapest. Quindi non la nomino, non la scrivo neanche per intero).
Chissà come sarà il ritorno, se sarò invasa dall’impotenza di quell’austero dominio, dallo spazio esageratamente presuntuoso, oppure no. Che colori avrà il Danubio d’ottobre?
La partenza è brutta. Dalla Liguria a Milano e da Milano Stazione Centrale raggiungo Lampugnano che è una stazione delle corriere e degli autobus ai margini. Aspettare un autobus a Lampugnano, cercare un bar fra angoli in frantumi di una periferia in frantumi per gli ultimi degli ultimi, pensata per fuggire e non per restare e per fuggire in fretta è come ferirsi. Ferirsi prima di partire, smarrirsi dove l’umano si smarrisce, dove non c’è calore. L’autostazione di Milano, la principale, è questo disastro. Resto immobile sulla piattaforma pentendomi dell’anticipo con cui sono arrivata. Luogo di transiti -per -forza. Quella di Bologna è più bella. Quella di Bratislava è viva, regale quasi, luminosa. Da Lampugnano, partono la maggior parte degli autobus che collegano l’Italia all’Europa e mi dispiace molto lo stato in cui la trovo, il disagio strisciante che si percepisce fuori e dentro. Il degrado, lo sfilacciamento del tessuto urbano, la provvisorietà e il freddo mi impediscono di rilassarmi, penso a chi arriva e ai suoi pensieri sul bilico italiano. Le autostazioni devono essere accoglienti, magari stranianti ma gentili, straripanti di bisogni e umanità, penso guardandomi attorno. Appena arriva l’autobus bicolore salgo e mi preparo al viaggio. Nomade sempre, sradicata dal tempo degli interni, delle cucine, dei piatti incrostati, dei benestare ottenuti a fatica dal proprio senso del dovere, dal tempo del cellulare consultato freneticamente per riempire il vuoto delle sere senza novità. Dal proprio home banking che dice sta attenta anche se si spende poco da quelle parti, di solito, ad est, esagerare.
Budapest è anche un ritorno di letteratura maestosa, di fasti che mi sono portata dentro a lungo e che sono pilastri fondanti. Scoprii Imre Ketesz e lessi tutti i suoi libri prima di venire la prima volta. La letteratura ungherese ha una ricchezza e una vastità che possono viaggiare insieme a chi aspetta di partire per infiniti andirivieni. All’epoca scartai gli altri, decisi per un’immersione totale, amai più Kertesz che la città e amai la città meno di Bratislava ma le vecchie capitali giocano partite diverse da quelle nuove che io di solito preferisco perché significano “cambiamento” (Anche Banja Luka è una nuova capitale nel suo modo obliquo, una capitale del niente e che nessuno conosce, una città sghemba che ancora non significa quello che vuole, che ancora, per la storia, è un ibrido imbarazzante, un’anomalia).
Il Flixbus è quasi vuoto e io occupo subito il posto accanto al finestrino e quello vicino con la borsa dove tengo tablet e quaderni, penne e libri di inglese perché dovrò anche fare qualche lezione da là nonostante la conferenza. Insegnare online vuol dire anche poterlo fare sempre, a volte doverlo fare sempre, così mentre lasciamo Milano mi ritrovo a preparare quella del mattino seguente, rivedendo la grammatica avanzata per il mio studente che prepara un Proficiency, l’esame che certifica il livello C2, l’ultimo, la conoscenza della seconda lingua a un “idiomatic level”. Ed è questa lingua che mi stacca dal freddo di Lampugnano, dalla sensazione che l’Italia debba ritrovare la sua stima nazionale a partire ANCHE da quelle piattaforme degradate, è questa lingua, la lingua che parlo con due ragazze ungheresi davanti a me, che ritrovo nei miei appunti, nel libro, in un romanzo che sto leggendo che mi prende e porta lontano.
Arriviamo a Budapest quaranta minuti in anticipo dopo fermate in luoghi definibili solo dalla traiettoria che si trova sulla applicazione verde e arancione del Flixbus ma in realtà luoghi candidi di nebbia e brina, freddi e destinati solo a discese e salite fra il sonno e la stanchezza. Budapest Népliget è una autostazione splendida, grandissima e confortevole. Arrivando ho visto un’alba ungherese sfumata e dolce come la carezza di chi conosce l’amore e la perdita e le periferie mi hanno riconosciuto mentre io riconoscevo loro.
Népliget lo pronuncio alla francese come se fosse un voluttuoso capo di lingerie, ma sono sicura che avrà un’altra pronuncia e la imparerò, intanto mi godo il privilegio più grande, il tempo. Ho tempo. Ho tanto tempo per l’anticipo e perché la conferenza comincia in tarda mattinata. Avere tempo può essere sconcertante, di solito non c’è, lo maltrattiamo, lo modifichiamo, lo obblighiamo a servirci, lo disperdiamo e disprezziamo, ci lasciamo affannare da deadline impossibili. Si distende davanti a me il tempo, libero e mio.
Nessun appuntamento per alcune ore, nessuna camera d’albergo già pronta. Nessuno da avvertire, nessuna ansia per chi affrettarmi. Niente. Posso ritornare, cambiare meta, prendere il Flixbus doppio per la Polonia che osservo fuori sulla prima pensilina, raggiungere velocemente Bratislava. Tutto. Quello. Che. Voglio. Quello che voglio. Per un attimo ci penso a raggiungere Bratislava, sono stata felice lì. Invece resto perché qualcosa accade. Libertà e tempo. Anche la scrittura che riemerge. Respiro. Perfetto. Voglio conoscere ogni angolo di Népliget, per prima cosa ci vuole un caffè e non tutti accettano l’euro. Se lo fanno, è sicuramente di malavoglia e si nota. Devo trovare dei fiorini, ma prima quasi supplico un ragazzo al bancone del primo bar che trovo di lasciarmi pagare così, mi manca la caffeina, devo berne uno e poi posso cominciare a ragionare. Sospira prima di prendere gli euro. Ecco le nostre sicurezze altalenanti di Schengenlandia che si sgretolano ancora una volta, le nostre certezze sfracellate. L’euro? Meglio di no. Hanno cominciato persino a Banja Luka ad accettarlo, ma Banja Luka è fuori dall’Europa, e forse questo conta. L’euro fa parte del sogno di Bosnia, di un’ambizione per il momento lontana, qui no. Nessun sogno, solo passanti veloci e una moneta che si cambia oppure no, che si accetta o no, niente euro, no euro please, no english please, guardi, al piano di sotto c’è un bancomat, no english, no german. Ok, ho colto il messaggio. Una ragazza sta ferma nell’angolo in cima alla scala mobile e distribuisce qualcosa di caldo e fragrante a tutti i passanti. Lo voglio anch’io. Regge un cesto con dei piccoli bocconcini caldi e salati, si può prendere, salire, ripassare e riprenderne uno o due, le sorrido e lei ricambia. Lo considero un benvenuto.
Népliget è la stazione degli autobus più lineare che io abbia mai visto. Interno, esterno, piano di sotto, piano di sopra, leggo che è aperta dalle 4 e 30 alle 23 e 30 e mi illudo ancora una volta che ci siano luoghi dell’accesso, luoghi dove si può stare senza essere cacciati, dove si può attendere, mangiare, bere o riposare. So che non è vero, non del tutto. So che i luoghi dell’accesso sono minacciati ovunque, e anche qui. Ma mi accontento dell’illusione, dopo Lampugnano sono colpita.
Mi siedo in una panchina in angolo con una bellissima visuale di chi va e di chi viene, prendo appunti dopo tanto tempo. La scrittura era diventata il peso enorme di un dolore che non potevo più raccontare, il lavoro mi aveva travolto e mi travolge ancora, ma questo tempo regalato mi riavvicina alla scrittura. Ero monca. Ero persa. Non ero io. C’erano l’inglese da insegnare, i bimbi, gli studenti gentili, gli esami IELTS, gli ebook, le notti per ottenere certificati e certificati, ma la scrittura era rimasta insieme a quello che mi sembrava di aver perduto. Perché di quello avevo scritto ultimamente. Solo di quello, della città oltre Gottardo, dei desideri che non trovavano compimento, della passione rincorsa sulle rive di un fiume molto più piccolo del Danubio, dell’amore tossico, della fuga e dei ritorni ancora e ancora. Fra quelle macerie era rimasta anche la mia scrittura, come se mi avessero strappato fegato e reticolo venoso, ma non bastava e ci voleva anche quell’atto necessario che da decenni scandiva ogni mia giornata. Era rimasta lontana da me, e quell’autobus, quell’autostazione me la stavano restituendo, stavano ricomponendo i pezzi strappati e i miei pensieri slabbrati ritrovavano frasi, cancellature, un pezzetto di ritualità necessaria. Era entusiasmante. Lasciai subito perdere l’idea di scrivere sul tablet, avevo (e ho) un magnifico quaderno arriva da Londra ed è sempre con me, così scrivo. Io in un angolo con la borsa fra le gambe scrivo e mi guardo intorno, immagino vite che si incrociano, e decido un destino per ognuno che passa. A Népliget l’autostazione drammaticamente bella scrivo delle periferie che si sono ricordate e hanno aperto le quinte del grande teatro imperiale che è questa antica capitale. Scrivo di quello che si perde e che si deve saper abbandonare. Poi vado a prendere un altro caffè, lo pago coi fiorini, e torno a sedermi.
Il tempo che ho è davvero tanto, dopo aver visto arrivare e ripartire decine di Flixbus e di autobus cittadini, dopo avere preso appunti fitti e cercato di capire il rapporto fra euro e moneta locale basandomi sul numero incredibile di monete che mi hanno dato di resto, decido di andare a vedere il Danubio. Non importa quale punto. Posso arrivarci, basta camminare un po’, il telefonino mi indica la direzione ed eccomi. Non mi interessa sapere dove sono, c’è un attracco e ci sono sparuti passanti. Il Danubio è verde scuro. Bellissimo, mi commuove. Anni fa feci un giro in barca, adesso tornano invece tutte le memorie che credevo di avere lasciato nel deposito che immagino prima di ogni frontiera (mi hanno turlupinato, le memorie possono solo arrivare e mirare alla giugulare, non si fermano dove vuoi tu, non restano quiete) Cosa resta dei fiumi che vediamo?
Cosa resta dei loro colori? Dei pensieri e dei dolori che ci invadono mentre camminiamo seguendone il corso? Cosa resta dei panorami e degli amori che diventano un’impronta visibile anche quando si allontaniamo?
Il Danubio come ogni fiume è memoria di impermanenza e ci dice che dobbiamo lasciare quello che eravamo durante quell’amore, uno specifico o tanti che abbiamo la fortuna o la sfortunata urgenza di vivere con tutta la nostra fiducia. Le città per fortuna rimangono. Le città, in quel senso, non ci possono fregare. Non tradiscono il nostro slancio ma solo se le amiamo, come diceva sempre Elias Canetti.
La conferenza si chiama Flying Colours e arrivo presto anche lì. Altro tempo per scrivere, per trovare ancora del caffè troppo lungo, ma dopo la notte in Flixbus mi fa molto piacere lo stesso. Ritrovo alcuni conoscenti, faccio qualche amicizia, prendo e distribuisco biglietti da visita, assaggio piatti ungheresi durante la pausa pranzo, da sola, guardando dalla finestra Villànyi Ut che è un po’ in periferia e ho quindi un debito per quel benvenuto. Un benvenuto fantastico, coi palazzoni geometrici, l’acciaio, il ferro e la polvere, le tracce di architettura socialista e il nuovo incombere di nero, vetro e cantieri che si erano fermati al mio passaggio, quasi inchinandosi nel riflesso sul vetro. La giornata passa anche troppo in fretta, a l’hotel l’ho scelto a caso ma è vicinissimo. Un labirinto, la camera piccola sembra un abbaino ma cosa 40 euro a notte con colazione compresa e io amo gli alberghi dove basta poco per tutto. Faccio le lezioni lasciate in sospeso, e torno alla conferenza per le sessioni pomeridiane. La serata è fretta, trucco attento, esagerato rispetto al mio solito e tre vestiti cambiati guardandomi con fatica nel piccolo specchio della stanza-abbaino.
Vorrei raccontare del ponte che collega Buda a Pest, del castello che riesco a visitare, della notte delicata al ristorante libanese con un amico che mi piace guardare mentre parla, pacato, delle novità della sua vita. Vorrei raccontare della ruota panoramica dove penso di voler salire ma poi decido che non è il caso. E ancora i colori della notte di Budapest (ogni notte ha colori diversi in ogni città, influenzata e disciolta dai lampioni, dai riflessi degli interni, dalle insegne 24/7) e ancora la ampiezza delle strade, la quantità di giovani, il riflesso del mio viso (a Bratislava era più bello, o erano le vetrine dei negozi più indulgenti).
Vorrei raccontare del Bastione dei Pescatori, della Basilica di Santo Stefano, della Biblioteca Nazionale Széchényi, della Sinagoga Grande, delle terme più famose e di quelle nascoste dove vanno solo gli ungheresi, ma non riesco, l’itinerario si confonde, tutto si sovrappone, è come se avessi evocato altre città austere, lontane indispensabili lettere ultime di geografie amorose.
Qui siamo solo alla B.
Il giorno dopo è un concentrato di passaggi, di camminate e taxi veloci, l’ultimo tassista mi parla a lungo in inglese e io dopo averlo aspettato diciotto minuti decido che vorrei sposarlo un giorno, tornando, perché mi ha salvato all’ultimo momento e non posso dire perché e da cosa. Mentre raggiungo di nuovo Népliget la guardo dai finestrini mentre scivola via dal mio campo visivo. Budapest è un sogno, liquido, magnetico e sontuoso.

Francesca Mazzucato
Scrittrice, traduttrice, consulente per case editrici italiane e straniere, dirige la collana dei Cahier di viaggio per Historica edizioni, è co-fondatrice della casa editrice digitale internazionale Errant Editions, tiene corsi di scrittura creativa, educazione alla lettura e di inglese per bambini. Ha collaborato a progetti con teatri e centri culturali italiani e stranieri sulla scrittura delle donne. Tradotta in Europa, USA e UK, collabora a magazine e riviste letterarie. Sulla sua opera sono state scritte alcune tesi di laurea. Ama Beckett, Marsiglia, Baremboim, tutti i romanzi di Harold Brodkey, la pioggia di Parigi, la Kunsthaus di Zurigo.